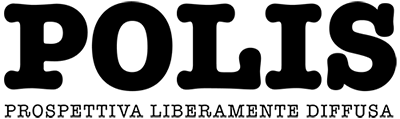Alle ore ventidue, mentre sto a casa in compagnia di una pizza salsiccia e cipolla accompagnata da una Peroni ghiacciata e con delle fitte dolorose dietro l’orecchio sinistro, che mi preparano sempre a qualcosa di peggio, mi telefona Gennaro Sacco, un amico fraterno, viceispettore di Polizia che ogni tanto mi passa qualche soffiata.
“Corri a Castelvolturno, a Baia Verde, una cosa grossa, un gruppo di fuoco di camorristi, hanno fatto una strage”.
Mi precipito giù per le scale, arrivo nel garage e mi tuffo nella Panda diesel che mi ha regalato mia madre. Con la bocca ancora piena e le cipolle che pensano di stare sul Titanic che sta affondando, faccio retromarcia, inserisco la prima e mi avvio sgommando.
Mi sento una specie di 007 dei poveri.
Alle ventidue e quaranta sono di fronte a una scena agghiacciante: il gruppo di fuoco di Giuseppe Setola ha colpito, sette morti. Il più vecchio aveva trent’anni.
La prova della resa incondizionata della nostra comunità alla camorra.
Ritorno a casa sconfitto, tradito dalla mia terra e dalla mia gente. Scrivo un “pezzo forte” e poi passo la nottata fuori al balcone a fumare. Almeno la notte è uguale in tutte le parti del mondo, chiudo gli occhi e immagino di essere in un altro Paese.
Il giorno dopo a scuola due ore di Italiano. Sono stanco, le emozioni della sera prima mi hanno sfinito, non ho dormito neanche un minuto. Guardo i ragazzi della seconda D in silenzio assoluto, rispondono al mio sguardo, spenti, arresi a questa terra degenerata. Mi fanno pena. Tutto quello che diventeranno nella loro vita, lo faranno in assoluto ossequio alla camorra: un ingegnere che farà progetti per la camorra, un politico che farà favori alla camorra, un commercialista che investirà i soldi della camorra, un medico che curerà le malattie della camorra. Fine.
Mentre mi accingo ad iniziare la lezione si spalanca improvvisamente la porta, entra un ragazzo ingelatinato, tatuato e abbronzato. Senza degnarmi di uno sguardo dice rivolto a un amico: “Jesce Giggì”, guardandomi poi in faccia con sufficienza. “Coccosa?” Sulla sua faccia si possono leggere tutti i motivi per i quali questa terra si è ridotta così.
Luigi Landolfi si alza dal suo banco e fa per uscire, assolutamente sicuro che nessuno oserà fermarlo. Allora, senza alzarmi dalla cattedra guardo in faccia l’apprendista camorrista: “Oggi Giggino non esce”. Poi mi giro verso Landolfi, secco, sicuro: “Tu, vai a posto”.
Di fronte alla mia sicurezza noto un momento di sconcerto, i due non sono abituati ad essere contraddetti. Dopo qualche secondo di incertezza dovuto alla sorpresa, il gorilla tatuato appoggia le mani sulla cattedra e abbassa la sua testa verso di me, poi in un dialetto napoletan-casalese quasi incomprensibile: “Tu ogge non t’arretire a casa toja”. Senza distogliere lo sguardo e con sorriso tiprendoperilculo, rispondo con un accento che è una caricatura del suo dialetto: “Tu ogge non jesce cu Giggino”.
La bestia ha gli occhi iniettati di sangue, sa che sta facendo una figura di merda. Mi prende per il bavero, io non mi muovo, non sa che fare, io mantengo gli occhi nei suoi, lui si gira, sputa per terra e se ne va sbattendo la porta. Luigi Landolfi è rimasto impietrito in mezzo all’aula, mi sembra quasi che aspetti ordini, gli intimo risoluto: “Vai a posto”.
Avrei potuto chiamare i carabinieri o il mio amico poliziotto, ma per mostrarmi impavido di fronte ai miei alunni decido di fare da solo. Un’idea da imbecille.
All’uscita di scuola tre cafoni, figli degeneri della mia terra, mi aggrediscono davanti a tutti i ragazzi per darmi la lezione che merito. Mi fanno male, mi fanno veramente male. Mi sono arrivati colpi da tutte le direzioni, sono una maschera di sangue, ho le ossa rotte, sono a terra, mi fanno male anche i pensieri. Nessuno mi aiuta, perché il più brutale dei picchiatori, prima di andare via ha urlato in faccia agli studenti: “O primmo che o’iza a terr’ o jamme a truvà stasera a casa soja”.
Dopo un attimo che è durato un’eternità in cui pensavo di morire come un fesso in mezzo al cortile della scuola, sento stranamente una mano sotto la mia testa. Riesco a stento ad aprire un occhio, è Luigi Landolfi che mi sostiene e mentre mi fa alzare mi dice con un filo di voce: “Uno cu ‘ddoje palle quadrate comme e vostre, non po’ murì comme a nu strunze ‘ccà ‘mmieze”.
Vincenzo Mazzarella
vincenzo.mazzarella@beniculturali.it