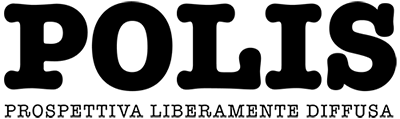Tra la fase 1 e la fase 2 di questa, necessaria – quanto non del tutto spiacevole – cattività in cui siamo relegati, esauriti gli spostamenti di arredo e riordinando carte varie ed affini (spesso risalenti a dir poco), mi sono imbattuto in un vecchio libro, acquistato tempo fa, presumibilmente, da mio padre, sempre attento, da umanista, a cogliere le interessenze tra il diritto – che gli dava da vivere, quale avvocato – e gli aspetti sociali che del primo influenzavano le evoluzioni normative. Il testo si chiama infatti “Una famiglia come un’altra”, scritto da Irene Bernardini ed edito dai tipi della Rizzoli. Ho cominciato pian piano a sfogliarlo, quasi con una certa reticenza, un po’ sospettosamente, immaginando tendesse ad avere una impostazione un po’ moralistica. Niente di tutto ciò, invece. Addentrandomi tra le pagine, l’ho trovato di grandissima attualità, tenendo conto che trattasi di un lavoro di quasi venticinque anni fa. Oserei dire, quindi, anche precursore di quanto sarebbe avvenuto in maniera quasi seriale, su larga scala, nei decenni successivi. Si tratta, infatti, di un manuale, quasi un vademecum, per lasciarsi senza rancore, salvaguardando, gli equilibri emotivi dei figli. Il tema, come dicevo, lo trovo molto interessante, rappresentando uno di quei casi in cui ad una decisione, apparentemente solo tecnica, si dovrebbe accompagnare una funzione di mediazione e composizione sociale che dovrebbe costituire spesso il fine ultimo del diritto civile, in special modo, quello di famiglia. Certamente questa composizione tra i vari interessi non avviene sempre nel modo migliore né in modo indolore. Tutti, infatti, sembrano conoscere la ricetta per una buona separazione e per un buon divorzio: i giudici, gli avvocati, gli psicologi. Basta leggere le sentenze, le memorie dei difensori, le relazioni di quei psicologi chiamati come consulenti tecnici dal magistrato. L’interesse del minore è il criterio principe, quello decisivo, in altri termini, quello in base al quale il giudicante si pronuncia nel dire quando e come il bambino deve stare con i genitori. E così nasce la regolamentazione dei weekend, dei ponti scolastici, dei compleanni delle vacanze. Spesso tutto ciò, tutto questo iter decisionale si accompagna ad un clima mesto di tristezza e, perché no, umiliazione per quei genitori separati che ritengono di essere in grado di valutare le esigenze dei figli senza intermediazioni di terzi, pur necessari talora, soggetti. Ma questo è un terreno minato: la famiglia si sfascia e necessita di regole etero determinate. In tal senso, l’autrice individua nella mediazione familiare lo strumento adatto a contribuire a dipanare i dissidi, non di rado violenti, emotivamente e verbalmente. Ma il libro, soprattutto, focalizza l’attenzione sulle famiglie allargate. Il riferimento è a quelle nuove unioni che seguono la separazione, da cui nascono altri figli, famiglie complicate che per alcuni sono solo sinonimo di disordine, in quanto impongono ai bambini di trovarsi uno spazio in un nucleo in cui c’è un uomo che non è il loro padre ed una donna che non è la loro madre e altri figli, fratelli unilaterali o semplicemente compagni di viaggio. Il concetto che viene fuori dalle righe è che le famiglie allargate non sono, in sé, né buone né cattive; tutto, in un senso o nell’altro, non è che il riflesso del modo di porsi affettivo nei confronti di chi non è, rispettivamente, il proprio padre o figlio biologico. Il punto cui sembra giungere l’autrice è che in effetti il discrimen giuridico coincide con quello emotivo reale, ossia con il punto di vista dei bambini e ragazzi, con la loro empatia. Capire insomma chi e come sta bene con chi, con le nuove figure adulti e “piccoli”. Non ci sono regole precostituite in sostanza e sarebbe errato porle. In tutto ciò, il punto di vista delle donne è decisivo perché, quasi sempre, su di loro ricadono gli oneri e gli onori delle famiglie allargate. La parte giocata dagli uomini è, va detto, raramente quella del protagonista: siamo il vero sesso debole. Ma sono, del resto, gli attuali tempi che definire “di cambiamento” risulta anche molto riduttivo. Bisogna reinventare e reinventarsi: in tutto, anche nel modo di volersi bene.
Vittorio Pisanti
vittopisanti@gmail.com