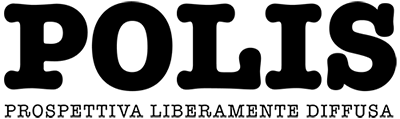L’unico antidoto per la malattia storica è “la storia stessa”.
Durante l’Umanesimo, la cultura ha riflettuto sull’instabilità delle cose umane e sulla consapevolezza della discontinuità con le epoche passate. Il senso storico nell’età moderna nasce dal confronto con i secoli bui del Medioevo. Il momento di crisi che oggi viviamo, ci spinge a riflettere sul pensiero del filosofo Vico che, nella sua opera sulla riscoperta del senso della storia, ha insistito sulla catastrofe che è in grado di riportare la civiltà al punto di origine e di far capire quanto sia fragile la struttura della civiltà e quanto dipenda dalle dinamiche storiche. Dal Novecento sino ad oggi, si è ripresentata la svalutazione degli studi storici, basti pensare al valore dell’attimo nei Mass Media con i post dei “social” che portano a vivere apparentemente in un eterno presente, privo però di memoria e di qualsiasi prospettiva.
Nietzsche nel 1874 ha indagato le origini della crisi della storicità nella cultura europea, tramite la pubblicazione delle quattro considerazioni inattuali, inattuali, poiché agiscono sul tempo e a favore di un tempo a venire.
Esse contengono una vivace critica nei confronti della cultura europea e, nello specifico, nei confronti della cultura tedesca dell’Ottocento, nella quale era immerso il filosofo. Egli nella sua opera identifica tre comportamenti dell’uomo rispetto alla conoscenza storica, attraverso i quali la storia risulta funzionale o meno alla vita. La prima è la storiografia monumentale che caratterizza colui che è spinto da grandi aspirazioni e ha bisogno di modelli e maestri del passato per agire e modellare il presente. La seconda è la storiografia antiquaria che caratterizza coloro che vedono la storia come fonte di modelli da preservare, coloro che si volgono al passato con fedeltà e amore. La terza è la storiografia critica, che infrange il passato, condanna la storia per liberarsi del passato inadeguato, per giungere a nuove azioni, necessarie per vivere e sviluppare la storia stessa. Dunque la storia deve essere un sapere funzionale alla vita, il suo eccesso è il sintomo evidente di una malattia più grave, ovvero la crisi della cultura, di una cultura vuota che cerca di colmare l’assenza di significato riempendosi dei materiali che le vengono messi a disposizione dalla storia e dalle scienze storiche.
Nietzsche così si oppone al positivismo, che riduce la storia a scienza fra le scienze. Ciò che ha reso la cultura tedesca nota al mondo è il male da combattere, cioè il risultato dello sviluppo degli studi storici.
Il filosofo attacca e condanna proprio il valore dell’imparzialità, dimostrando che l’esito ultimo dell’oggettivismo consiste nel giungere al punto che colui che si rapporta alla disciplina che studia il passato, lo fa con distacco e freddezza come uno scienziato che esegua i propri esperimenti, quindi subendo l’imposizione di non dover prendere posizione. In realtà, per Nietzsche, deve esserci un coinvolgimento pieno in ciò che viene trattato e solo grazie alle più alte e nobili qualità si intuirà ciò che del passato è grande e degno di essere conosciuto e preservato. Non c’è oggettività da promuovere, ma la reinterpretazione creativa del passato è il punto di vista dal quale si può partire per agire nel presente in prospettiva futura. Gli effetti negativi dell’eccesso di storia ricadono sulla formazione degli uomini e hanno come conseguenza la distruzione di ogni entusiasmo, l’annullamento di ogni capacità di sognare, di creare qualcosa di nuovo, tipico della gioventù, la cancellazione di ogni impulso. Nietzsche focalizza così l’attenzione sull’oggettivismo storico maggiore espressione della cultura decadente, anche se il suo linguaggio ambiguo non lascia intendere se ad essere condannato è solo l’oggettivismo storiografico, oppure ogni sguardo rivolto al passato.
Per Nietzsche colmare il vuoto della cultura nella quale si è immersi si esprime nella rottura con il passato. Bisogna avere il coraggio di dimenticare; avere la capacità di guardare ciò che si sottrae alla storia, quindi l’antistorico è il sovrastorico, come le potenze dell’arte e della religione si sottraggono al fluire delle cose umane. Solo attraverso l’antistorico e il sovrastorico forse si può guarire dalla malattia storica, cioè si può avere la possibilità di riguadagnare un rapporto positivo con il passato, recuperandolo senza cancellarlo attraverso l’organizzazione del caos in forma. Come scrive ne La nascita della tragedia, i Greci riuscirono a concepire una dialettica positiva tra vita e forma, tra vita che fluisce e forma che prova a fissare e stabilizzare. Questo dunque può essere il senso della conoscenza storica: comprendere la dinamica di apollineo e dionisiaco, equivalenti strutturali di caos e forma il cui risultato è l’armonia, come elementi fondamentali del divenire storico. L’armonia che racchiude l’impulso vitale e la stabilità della forma nella consapevolezza dell’assenza del senso della vita umana, si infrange con il razionalismo Socratico, pertanto il fluire non si deposita più in una forma, ma l’eccesso di forma soffoca l’impulso vitale ovvero il dionisiaco.
La cultura occidentale è la conseguenza negativa della rottura dell’armonia. Nietzsche parla, infatti, di deriva intellettuale cioè di una conoscenza che non è funzionale alla vita, ma la blocca e la annichilisce. Lo stesso George Simmel, parlando della “tragedia della cultura moderna”, afferma che l’uomo passa da liberazione ad alienazione, poiché l’uomo si riscopre in un orizzonte costituito da opere prodotte da lui stesso in una prospettiva di liberazione, ma poi prodotti come le scienze, l’economia e la società che sono diventati autonomi, fissi e stabili, dall’orizzonte di liberazione (risultato della produzione) passano a diventare mezzi di soppressione della libertà. Il risultato dell’autonomia dell’uomo si capovolge nel fatto che ormai è alienato dai suoi stessi prodotti.
L’unico antidoto per la malattia storica è la storia stessa, ovvero la riscoperta di una dimensione autentica della conoscenza, dell’attribuzione di un nuovo significato al passato che non è contenuto nella tradizione ma è ciò che ogni uomo deve creare liberamente in funzione della propria visione del presente e della speranza futura.
Gabriella Renzi – III D
Liceo Classico della Comunicazione P. Giannone