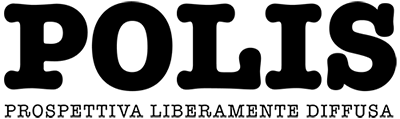A volte leggiamo una “notizia” e desideriamo fortemente che sia vera. Può capitare a tutti di cedere a quel desiderio e condividere un articolo o un post, contribuendo a diffondere un falso. Ogni giorno decine di persone fra i miei contatti – degne di stima, sensibili, generose in tante situazioni del quotidiano – condividono testi che ricostruiscono situazioni grottesche o scenari fasulli. Comprendo quanto sia difficile vagliare le fonti primarie o secondarie, soprattutto perché la scuola ci ha offerto scarsi strumenti per affrontare queste sfide. Da un sondaggio che ho recentemente effettuato fra i miei contatti Facebook e i miei studenti dei corsi di laurea triennale in Storia, Lettere moderne e Filosofia dell’Università di Napoli Federico II – un’indagine quindi artigianale, ma pur sempre indicativa di una tendenza – è emersa una situazione chiara: circa il 93% degli intervistati (400 persone in totale) ha dichiarato di non aver mai affrontato nello specifico, durante il percorso di formazione delle superiori, il tema della distinzione fra fonte primaria e fonte secondaria. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che anche i più attenti cadano facilmente nei tranelli trovandosi a condividere false notizie, soprattutto nei casi in cui queste ultime sono confezionate con sapienza e tengono conto delle aspettative del pubblico, andando a toccare corde sensibili, stuzzicando pregiudizi e paure consolidate.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi su questo tema e hanno coinvolto diverse discipline, come l’antropologia la sociologia, la psicologia, i media studies, la storia, la linguistica e la filologia. I risultati sono spesso discordanti e ci dicono chiaramente che la strada da fare è ancora tanta. La domanda più spinosa riguarda il carattere inedito del fenomeno: le false notizie rispondono a un modo nuovo di definire i processi di disinformazione o erano già presenti in passato nello scontro politico? Le divergenze più significative emergono dal doppio versante delle scienze sociali (come la sociologia e l’antropologia) e degli studi più propriamente umanistici (come la storia e la filologia). Si pensi ad esempio al libro di Giuseppe Riva, professore di Psicologia della comunicazione nell’Università Cattolica di Milano, intitolato semplicemente Fake News (Bologna, Il Mulino, 2017). Secondo l’autore, ci confrontiamo oggi con il “risultato di un lavoro di ingegneria comunicativa e sociale totalmente nuovo”, in grado di influenzare soggetti e gruppo “con una velocità e un coinvolgimento mai visti prima nella storia della disinformazione”. Opinioni totalmente contrarie sono espresse da storici e filologi, i quali stanno dimostrando ampiamente che l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione non ha mutato in maniera decisiva la tendenza a condividere in maniera spontanea e partecipata informazioni che sono reputate attendibili.
Uno dei nodi più spinosi rimane quello della verifica dell’informazione. A tal proposito, mi limiterei a una semplice osservazione: quando ci troviamo di fronte a una notizia, in molti casi non abbiamo la possibilità concreta di trovare prove inconfutabili della sua veridicità. Possiamo rivolgerci a esperti, consultare documenti e fonti “primarie”, ma non sempre il nostro lavoro ci riconduce a delineare scenari privi di ombre. In questi casi, l’unico soccorso ci viene dalla consapevolezza che la costruzione di una notizia è, prima di tutto, un fenomeno culturale.
La mia esperienza di fruitore di social network mi induce continuamente a riflettere sulle radici di alcuni comportamenti in rapporto alla trasmissione di informazioni. Quello che mi stupisce non è la tendenza alla condivisione incontrollata di false notizie, bensì la paurosa assenza di dimestichezza col concetto di verosimiglianza. Probabilmente lo stesso dualismo rigido fra vero e falso non offre sbocchi costruttivi, soprattutto nell’uso strumentale che ne fa la propaganda politica. Quest’ultima ha tutto l’interesse a produrre divisioni manichee della realtà: non tende a facilitare lo sviluppo di idee complesse o contrapposte, ma al contrario bada soprattutto a dividere il mondo fra sinceri e bugiardi. Chi studia l’informazione farebbe bene a non piegarsi a queste semplificazioni, guardando invece con più attenzione allo sviluppo delle sensibilità che portano individui e comunità ad accettare alcune notizie come genuine. In definitiva, bisognerebbe interrogarsi con maggiore convinzione sui processi culturali che portano al riconoscimento del verosimile, sulle loro stratificazioni, sulla possibilità di renderli maggiormente condivisi. Forse è utopistico definire il vero, ma almeno possiamo metterci d’accordo su ciò che è plausibile.
Pasquale Palmieri
pasqualepalmieri78@gmail.com