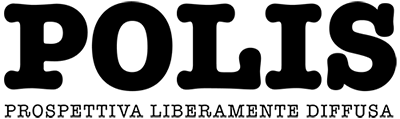Quando nel 1997 il professore della Columbia University Giovanni Sartori pubblicò ‘Homo videns’, mai avrebbe potuto immaginare che la sua teoria sulla deriva della società delle immagini avrebbe trovato, nei lustri successivi, una conferma ben peggiore di quella già denunciata sui danni fatti dalla televisione.
Quanto denunciato dal professore, tra l’altro illustre politologo, si è poi verificato in forme ancora più estreme e oserei dire, grottesche. L’Homo videns di Sartori era l’uomo che imperniava tutta la sua vita, le sue funzioni, il suo stesso sviluppo sociale, culturale e cognitivo, sull’apparire, sul mostrarsi, sul dare unica importanza a ciò che vedeva più che a ciò che pensava. In un processo involutivo per il quale, per la prima volta nella storia della specie, il progresso mentale subiva una frenata e faceva registrare addirittura dei passi indietro. L’uomo che crede solo a ciò che gli appare. Che non riflette più sul significato delle cose. Che dà importanza assoluta all’immagine. Che mette da parte il pensiero. La riflessione. L’introspezione. L’analisi. A vantaggio esclusivo di tutto ciò che appare ai suoi occhi. Preso come modello di riferimento. Verità assoluta. Ciò che vedo (o mi fanno vedere) è ciò che conta. Che vale. Che esiste. Il resto no. Il resto che non vedo non esiste. Non è mai esistito. Allora è importante mostrarsi. Apparire. Sembrare. Rendersi visibili quanto più sia possibile farlo. E al diavolo la privacy, che pure sembrava essere diventata l’unica cosa che contava. I social, Facebook in testa, hanno fatto le loro fortune su questo modello. Con l’illusione di essere meno periferici e inutili nel mondo, hanno dato alla gente l’ebbrezza di essere qualcuno, di avere tanti amici, di essere ascoltati, capiti, seguiti, apprezzati dai contatti virtuali. Un surrogato degli antidepressivi, per sentirsi meno soli, meno vuoti, meno inutili. Sorrisi stampati sui volti e usati come correttori d’infelicità, in un’ottica per la quale, se sono triste e ho mille problemi, ciò che conta è mostrarmi agli altri sereno e realizzato, per compensare nel mondo virtuale il fallimento della vita reale. Capita così che, nella società del primato dell’immagine, del netto prevalere del visibile sull’intelligibile, nella quale vedere conta più di capire, apparire più di essere, mostrarsi più di sentire, avvenga una sorta di incredibile mutazione/regressione dell’apparato cognitivo. Un’involuzione genetica che crea un nuovo analfabetismo, non più basato sul non saper leggere, scrivere e far di conto ma sul non saper pensare, né riflettere, né immaginare nulla che non sia ciò che ci viene proposto dalle immagini. Ovvero ciò di cui abbiamo immediato riscontro. Una società nella quale i bambini non hanno più tempi vuoti, tutti follemente occupati da una serie di attività che allenano il fisico e ingessano la mente. è sparito il pomeriggio senza niente. Quello in cui si inventava un gioco. Lo si costruiva dal nulla, sviluppando una creatività sempre più mortificata. Mi sono sgolato, nella scuole, per far capire a mammine isteriche che sballottare i propri pargoli da una palestra all’altra, non era cosa utile. Né buona. Né funzionale alla loro crescita. Nulla da fare. Mi guardavano quasi inebetite, come se stessi dicendo loro una boiata. Erano le stesse che, una volta almeno a settimana, dovevano andare per forza dal parrucchiere. E poi dall’estetista. E poi dalla manicurista. Nulla di cui meravigliarsi, se al tempo del pensiero zero, tra le poche attività che invece di ridursi hanno aumentato i loro affari, ci siano tutte quelle che si dedicano all’aspetto estetico. Sembra che le famiglie non abbiano soldi per nulla. Eppure per unghie tigrate, appuntite da spaventare un’aquila, mezze disegnate con motivetti che manco all’asilo, si trovano sempre. Così come per rifarsi i capelli, seguendo l’ultima acconciatura del parrucchiere di grido. Bravo nel coccolare le clienti. Nel farle sentire delle principesse. Delle reginette da adorare. Da invidiare. Alle quali rivolgere raffiche di complimenti riciclati per l’occasione, sparati fuori tra l’odore del borotalco e quello di creme cinesi come quelle dei cinesi, ma spacciate per prodotti d’eccellenza. Vedo a volte uscire da moderni saloni, tutti luci al neon, queste signore depresse con le bambine al seguito, acconciate come loro. Stesse movenze. Stessa andatura. Adultizzate senza neanche il tempo di giocare con le bambole. Escono, le signore, con un’aria di sicurezza data dal nuovo taglio, convinte di far squagliare qualsiasi uomo capiti a tiro. Alla fine, attireranno i soliti sguardi dei soliti guardoni, disperati almeno quanto loro. Sarà forse stato per l’unico momento di consapevolezza dei propri limiti. Che dobbiamo riconoscere assieme ai nostri meriti. Per evitare di cadere nella trappola di sentirci unici e indispensabili. Perché unici e indispensabili non lo saremo mai. Per nessuno. è la doccia fredda che dobbiamo riversare quanto prima sul nostro ego. Surriscaldato dalle correnti narcisistiche. Trascinato su piedistalli farlocchi. Gonfiato come i muscoli nelle palestre da una società che, in cambio di un finto primato, s’è presa la nostra anima e ci ha resi tutti più soli. E da soli non ci salviamo.
Aldo Taraschi
taraschipsicologo@libero.it