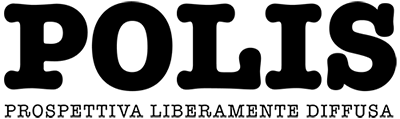Ernest Hemingway, parlando dell’Italia ed in maniera particolare del suo popolo, mise in evidenza una caratteristica peculiare. Il narratore americano ebbe modo di tessere le lodi dell’innato spirito di conservazione. Questa genetica propensione a lanciare in avanti la conoscenza e la storia verso una dimensione temporale posta oltre e non tangibile è evidente soprattutto nelle genti del Sud. La spinta progressista della volontà di non mettere da parte il passato rinvigorendolo quotidianamente fino ad innalzarlo ad un costante presente si manifesta plasticamente anche sulle tavole accerchiate da inconsapevoli testimoni e connettori infiniti della saggezza culinaria. L’idea si concretizza con sfacciata chiarezza nel rituale ancestrale del riempimento del “buccaccio”.
Non si tratta, come superficialmente potrebbero considerarlo i non indigeni, di un banale contenitore di vetro, ma di una teca con la responsabilità sacra di custodire, tra i tanti miracoli, le figlie della luce dei pomeriggi ardenti d’estate.
Le melanzane si affacciano alla vita agli esordi della stagione buona sotto forma di virgulti violacei che si ergono fieri verso un avvenire di compostezza e predisposizione verso il prossimo. La caritatevole dama dei campi, avvolta in elegante abito nero, affronta la maturità con equilibrio e sobrietà, rannicchiandosi leggermente su sé stessa sotto il gravoso peso dell’esperienza che non guasta la linea sinuosa, segno ancora presente di una gloriosa giovinezza.
Una volta raccolte, il “buccaccio” si fa custode della loro grandezza eterna dopo un passaggio di stato che le trasporta verso la leggenda.
Una preziosa anfora cesellata con nervuti intagli verdastri dell’ortaggio che si è innalzato al divino liberandosi della terrestre zavorra dell’acqua, passando per il purgatorio del sale e attraversando gli inferi del bollente aceto, impreziosita da minuti coralli di aglio, da scintillanti gemme di peperoncino e suggellata da una pioggia di polvere di brillante origano.
Il boccaccio diviene guardia della bellezza immortale, che sconfigge il tempo e che diventa fonte di verità assoluta e strumento magico di risoluzione di umani dilemmi.
Etimologicamente destinata ad assurgere al ruolo di oracolo, a fronte del richiamo al sostantivo femminile latino ‘bucca, ae’, la preziosa ampolla votiva assume la funzione parlante ai comuni mortali come il vaso di Delfi con le sorti sul tripode della Pizia.
Il boccaccio di melanzane diventa risolutivo come quando i sacerdoti dell’Antica Grecia erano incapaci di rispondere alla folla, dimostrandosi decisivo per cancellare le paure del suono demoniaco del citofono che preannuncia l’arrivo inaspettato di ospiti a cena.
Un vaso sacro che va tenuto nelle tenebre, al riparo dagli attacchi di quadriforcute lance di spietati untori, capaci di minarne le virtù soprannaturali, affondando le punte contaminate nelle sue viscere per disseminare la malasorte che si manifesta sotto forma di botulino.
Un simbolo di una civiltà evoluta, capace di infrangere la barriera spazio-temporale cosicché anche un muratore del tremila, posto davanti al suo ritrovamento, non avrebbe dubbi: Trattasi di un’opera d’arte e non di un cesso scassato. Non un Wesselman, ma uno Sposito. Maria Sposito, mia zia.
Nicola Maiello
nimacomunicazione@libero.it