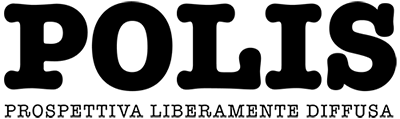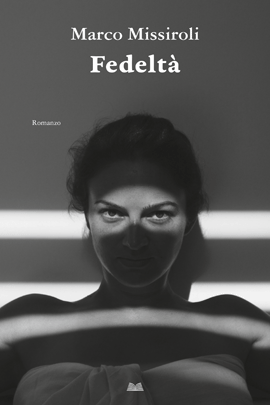Storie di abbandono, di diversità, di emarginazione. Dolore e sofferenza impregnano i muri del complesso di edifici affacciato sullo splendido porto naturale di Lakki, a Leros, isola greca nell’Egeo orientale. Isola che, come molte altre del Dodecanneso, è stata colonia italiana, dal 1912 fino al 1947, anno in cui si riunisce alla Madrepatria.
Costruito negli anni ’30 dagli italiani come base militare della Regia Marina Italiana, il complesso ha ospitato circa settemila militari italiani, in caserme, magazzini, officine, villette per ufficiali e uffici, fino alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1950, con un decreto reale, per contrastare la crisi economica e prendendo spunto dalla necessità di ridurre l’affollamento dei vari ospedali psichiatrici esistenti in Grecia, fu fondata la colonia di Leros per psicopatici, il “manicomio” di Leros, per i malati, i disadattati, i diversi, cioè coloro che non trovavano spazio nella società greca dell’epoca. Nacque, allora, una vera e propria deportazione psichiatrica. Nel 1965, quando gli internati erano ormai 2650, prese il nome di ospedale psichiatrico, il più grande ospedale psichiatrico d’Europa. Un luogo infame, in cui durante il regime dei Colonnelli, tra il 1967 e 1974, furono trasferiti anche i detenuti politici e poi gli orfani della guerra civile. Le scritte sui muri, alcune ancora visibili, sono il segno della coercizione mentale e psicologica cui erano sottoposti i “rinchiusi”.
Gli infermieri non erano infermieri ma guardiani, contadini e pescatori che avevano avuto così la possibilità di un impiego statale in un periodo di grande crisi.
Sotto la costante pressione della comunità internazionale, agli inizi degli anni ‘90, si diede il via ad un progetto (che vide la collaborazione tra il direttore greco dell’ospedale e del progetto e una equipe di Trieste) che prevedeva la deistituzionalizzazione all’interno dell’ospedale tramite l’abbattimento di ogni muro, la restituzione di libertà e diritti e il successivo intervento di riabilitazione e ricostruzione delle singole soggettività.
Intervento che spaventò gli abitanti dell’isola per un duplice motivo:
– molti di loro lavoravano all’interno dell’ospedale e in questo modo, con la chiusura della struttura, vedevano svanire la possibilità di un lavoro certo;
– se i “rinchiusi” fossero ritornati alla libertà, se i “matti” avessero iniziato a circolare per l’isola, ci sarebbero stati problemi per la sicurezza degli isolani e per l’attività del turismo.
E, invece, l’uscita degli internati, con gli operatori, per le strade dell’isola ha consentito una graduale e reciproca conoscenza ma anche l’individuazione da parte di alcuni proprietari di bar, ristoranti e negozi di una nuova fonte di reddito.
La comunità dell’isola ha recuperato, con lo sviluppo di queste esperienze, valori di civiltà.
Da anni ormai, il complesso è in stato di abbandono, ma a conferma del fatto che ci sono luoghi che sembrano dover assolvere per sempre la stessa funzione, in una parte di esso sono stati istituiti i centri di accoglienza per i profughi siriani.
Giuliana Rogano
giulianarogano@gmail.com