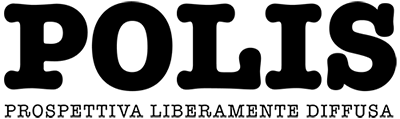Non è dato all’essere umano riempirsi gli occhi e la mente di tutta la Storia e del sentire di tutte le epoche, gli è dato piuttosto interpretare tutta la Storia secondo il proprio sentire, frutto dell’epoca a cui egli stesso appartiene. In passato, in opposizione alla percezione di noi contemporanei, un irrigidimento della forma di Stato o delle pressioni reazionarie sarebbe stato comprensibile. Tuttavia anche la nostra democraticissima società è attualmente percorsa da fremiti di questo tipo, com’è possibile? Forse è il caso di pensare al tessuto della Storia come a un cuore umano pulsante in cui le fasi di tensione e rilassamento corrispondono a quelle di contrazione e rilascio note, in ambito medico, col nome di sistole e diastole. Nel corso del tempo si vengono ad accumulare tensioni che, in condizioni particolari, possono portare a un congestionamento del sistema costituito. Dopo le condizioni di Versailles la Germania versava in condizioni disastrose, si risollevò una volta rientrata in possesso delle proprie risorse minerarie, poi crollò nuovamente pochi anni dopo a causa della crisi del Ventinove; tutti sappiamo cosa sarebbe avvenuto di lì a brevissimo, cioè nel Trentatré. In quel caso, oltre alle tensioni già presenti e mai sopite, fu la crisi economica a fungere da catalizzatore per l’avvio di un sistema di chiusura. La società si muove per mimesi, sulla scorta dei comportamenti umani; non sarà semplice convincere il bambino impaurito dal buio che sprofondare nelle coperte costituisce una protezione efficace. La ‘chiusura’ è percepita dall’essere umano come ‘protezione’; non stupisce affatto, dunque, che sia proprio questa ad essere riproposta da chi, impaurito da alcune condizioni come il bambino dal buio, cede agli impulsi reazionari. La nostra epoca è caratterizzata da almeno quattro fenomeni che costituiscono il punto di svolta: la globalizzazione, il trionfo dell’era digitale, la rivalsa dei territori a lungo colonizzati dal Vecchio Continente e, recentissima, la pandemia da Covid-19. La globalizzazione si è opposta ai confini, innescando un meccanismo per cui tutto il globo è in relazione; il problema di una porzione di mondo può potenzialmente estendersi a tutte le altre. L’era digitale non rappresenta solo una svolta per il progresso, ma anche un motivo di esclusione sociale; la rapidissima evoluzione in questo campo rende obsolete le conoscenze delle generazioni precedenti, generando un divario sociale e un terreno floridissimo per l’insorgenza di focolai reazionari. Venendo al terzo fenomeno, la preminenza europea è in netto declino; il punto di forza degli europei, che disponevano di tecnologie adeguate ma non di risorse, era in passato lo sfruttamento di quelle dei territori colonizzati. Oggi, tuttavia, nazioni come la Cina o l’India dispongono sia di tecnologie che di risorse, ovvero dei requisiti necessari per l’esautorazione dell’Europa. Infine, le tensioni generate da queste profonde metamorfosi sembrerebbero poter essere catalizzate proprio dal Covid-19 e, in particolare, dalle sue conseguenze economico-sociali. Una pandemia che in Europa, come abbiamo visto, non ha sempre messo in rilievo lo spirito collaborativo dell’Unione, ma che anzi ha fatto emergere vistose discrepanze. Poi ci siamo noi (esseri umani), piccoli figli del nostro tempo. Ci immergiamo in acque che non riconosciamo e diciamo che sono sporche, o troppo fredde, o troppo e basta; ma i tempi cambiano e quando i re muoiono si ha sempre un ultimo guizzo di ribellione dei sudditi fedeli che si oppongono al nuovo ordinamento. Il cambiamento fa paura, come il buio per i bambini. La chiusura che ne consegue è il tipico senso dell’essere reazionario: il futuro è incertezza, l’identità è sfumata, i connotati del popolo a cui si appartiene non sono che gli ultimi filamenti dell’ombra che si estingue nell’oscurità. Ed ecco che si ha un attaccamento ai valori tradizionali, quelli che a lungo si sono intesi come caldi, protettivi, familiari: il contadino da cui si acquistano le uova, la madre custode della casa, il padre che lavora: il reazionario non capisce che anche al contadino sta bene lavorare meno delle consuete sedici ore e che l’univocità del ruolo maschile e femminile abbatte il diritto di essere chi si vuole. Ma in fondo è pur vero che, quando si raggiunge un discreto stato di benessere, è assai comune dimenticare le iniquità del passato.
Nicola Di Nardo
nicoladinardo92@gmail.com