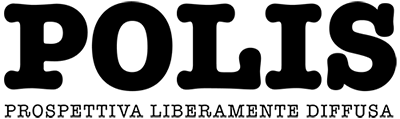Nel corso di una giornata ordinaria, in tempi di quiete, migliaia di ‘stranieri’ entrano ed escono dal perimetro cittadino di Napoli con una frequenza che a qualcuno non sfugge. Per noi che veniamo dalla Provincia vige un obbligo imposto da una legge non scritta ma particolarmente stringente. Esiste un controllo gestito sul modello CIA/KGB che fa capo a navigate agenti segrete, identificate con nomi in codice che presuppongo il prefisso ‘Zi’ anziché ’00’ (Zi Carmela o Zi’ Maria prevalentemente), che governano la rete di ispezione dai tinelli dei piccoli comuni dell’hinterland. Non esiste nessun cittadino campano, non residente entro le mura della città, che possa rientrare a casa da un soggiorno occasionale nella metropoli senza il dolce visto. All’uscita della Tangenziale, in fila al casello compaiono cugini di terzo grado o improbabili amici di famiglia, che fingono sorpresa ma che lavorano celatamente al soldo delle funzionarie perfettamente mimetizzate. Dopo esserci accertati della provenienza, alla stregua di integerrime guardie doganali, chiedono di esibire la ‘guantiera di sfogliatelle’.
Una sorta di permesso di uscita, un passaporto che viene definitivamente vidimato sul pianerottolo prima di oltrepassare la soglia della sede centrale del coordinamento dell’osservatorio. Sei vai a Napoli, devi ritornare con le sfogliatelle.
La distinta principessa della pasticceria partenopea ha anch’essa paradossalmente origini da una migrazione. È una napoletana di seconda generazione, capace di integrarsi fino a divenire simbolo di appartenenza di una comunità definita. Nata all’ombra della cucina nel conservatorio di Santa Rosa da Lima, nei pressi di Amalfi, dall’incrocio occasionale di un ripieno di pasta di semola, frutta secca, zucchero e limoncello con un cappuccio di pasta frolla, battezzata Santarosa, venne adottata agli inizi dell’Ottocento dal napoletanissimo Pasquale Pintauro e portata in città cambiandone i dati anagrafici, attualmente in uso.
Da quel momento iniziò la celebre questione amletica legata all’opzione ‘riccia o liscia’, a seconda dalla scelta di accogliere il cuore tenero e rassicurante in una placenta di pasta frolla o sfoglia.
Si tratta di una scelta che presuppone una predisposizione dell’animo, ma che in ogni caso racchiude in sé le due variabili prevalenti della napoletanità, che spesso convivono ma non sono evidenti agli osservati più superficiali.
Mangiare la riccia implica la disponibilità al movimento, all’eventualità di essere visibili alla comunità nell’atto in cui si genera la deflagrazione di scaglie impazzite di gioia come le scintille dei fuochi di artificio nei giorni di festa, che si trasformano in una melodia popolare generatrice di una danza ancestrale, antidoto contro la malinconia.
Comunicarsi con la liscia è un atto più intimo. La consistenza di questa tipologia di sfogliatella richiama la contemplazione, l’attitudine ad affidarsi, a concedere fiducia nel porsi in maniera positivamente fatalista all’onirica confidenza di una miscela di essenze dal sapore materno.
Due sfaccettature che sintetizzano l’unicità di una pacifica e irripetibile enclave.
Nicola Maiello
nimacomunicazione@libero.it