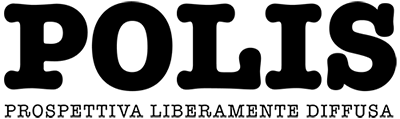Un marinaio che sappia dove andare e possa quindi essere accompagnato dal buon vento, ha comunque necessità di rilevare giornalmente la propria posizione geografica, il punto nave, per verificare gli eventuali scostamenti dalla rotta definita. Ha quindi bisogno di un sistema di riferimento, che nel caso della navigazione marittima (e terrestre) e’ quello determinato, nel 150 dC, dal cartografo e astronomo Tolomeo, con il suo reticolo di linee di latitudine (paralleli) e longitudine (meridiani). Mentre la determinazione della latitudine, ovvero della posizione a Nord o Sud dell’equatore, era un esercizio relativamente semplice basato sul rilevamento di elementi quali la lunghezza del giorno o l’altezza, sopra l’orizzonte, del sole e delle stelle principali, il calcolo della longitudine, necessario a incrociare il dato Nord-Sud con quello Ovest- Est, per essere affidabile e possibilmente esatto avrebbe richiesto la registrazione della differenza, in un dato momento, tra l’ora solare rilevata da bordo e quella nel porto di provenienza o in altro punto di cui si conoscesse la latitudine. L’assenza di un affidabile metodo empirico che permettesse di rilevare, anche attraverso la longitudine, il punto nave ed evitare le innumerevoli tragedie del mare dovute soprattutto agli incagliamenti e alle perdite di rotta, rese quindi necessario, 24000 anni dopo l’inizio della storia della navigazione dell’uomo, lo sviluppo di un idoneo strumento o metodo di calcolo del punto di longitudine. Fu così, come ci racconta Dava Sobel nel suo bel libro, “Longitudine”, BUR Rizzoli, di cui raccomando la lettura, che il parlamento inglese, con il Longitude Act del 1714, stanziò una somma incredibile per quel tempo, dell’ordine di diversi milioni di Euro di oggi, da dare in premio a chi inventasse uno strumento in grado di permettere il calcolo esatto della longitudine. Sicuramente stimolato oltre che dalla fama che l’impresa gli avrebbe assicurato anche dalla notevole somma in gioco, un orologiaio inglese di straordinario ingegno, John Harrison, con anni e anni di massacrante lavoro e numerose repliche sempre meglio perfezionate, realizzò un orologio senza pendolo per l’uso navale, azionato da una macchina che, grazie ai materiali utilizzati, era quasi del tutto priva di attrito e quindi poco necessitevole di lubrificazioni, capace di mantenersi in equilibrio neutralizzando gli effetti delle accelerazioni, prodotte dal rollio e beccheggio e insensibile alle variazioni di temperatura. Dopo lunga osservazione a bordo delle navi della Flotta di Sua Maestà e le positive relazioni dell’Ammiragliato, in barba alle malevoli critiche ricevute dalla comunità scientifica, per aver egli risolto il problema che astronomi famosi come Galileo, Cassini, Huygens, Newton e Halley credevano di poter risolvere solo con l’osservazione della luna o delle stelle, John Harrison fu alfine ritenuto meritevole del premio previsto dal Longitude Act che, gli fu così conferito, nel 1773, dal Re Giorgio III. Si apriva una nuova e definitiva pagina della storia della navigazione fino ai moderni sistemi satellitari, come GPS e Galileo, evitando i mortali rischi del passato e assicurando al navigatore la ragionevole aspettativa di non perdere la rotta.
Pio Forlani
forlaniforlani@gmail.com