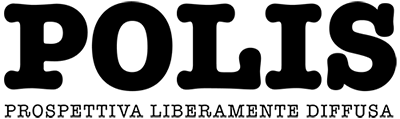Alzare lo sguardo verso il cielo e chiedersi cosa c’è oltre il Sole, la Luna ed i Pianeti del nostro sistema solare è una cosa vecchia come il genere umano alla quale, solo da poco, possiamo dare una risposta esauriente, una risposta che rappresenta una delle più grandi conquiste dell’uomo.
In effetti, fino al 1570 non siamo andati oltre il Sole al centro del sistema con i pianeti che vi girano intorno e con tante altre stelle immaginate in una specie di cornice che circonda tutto, come rappresentato in questa mappa (foto 1)
Nel 1570 avvenne un fatto straordinario, che diede inizio al nostro viaggio verso la conoscenza. Una Supernova di tipo 1a, una stella morente, luminosa miliardi di volte più del Sole, fu visibile, anche in pieno giorno, dalla Terra. La cosa incuriosì ed intimorì tantissime persone: la spiegazione più diffusa fu che era la stessa stella comparsa 1.500 anni prima ad annunciare l’arrivo di Cristo e che, quindi, bisognava aspettarsi il suo ritorno. Improvvisamente però, così come era comparso, il bagliore cominciò ad affievolirsi e poco a poco scomparve.
Uno dei tanti che avevano osservato il fenomeno, un inglese, Tomas Digges, pensò che forse la stella non si era spenta, ma solo allontanata fino a scomparire. Non era così, ma questa idea lo portò a pubblicare una mappa diversa del cielo nella quale le stelle avevano lasciato la precedente posizione “a cornice” per sparpagliarsi nel cielo (foto 2).
Per il passo successivo occorsero circa 200 anni.
Siamo alla fine del ‘700, a Bath, in Inghilterra e William Herschel, un maestro di musica ed astronomo dilettante inizia a costruire, sfruttando un’idea di Newton, una nuova generazione di telescopi usando lenti riflettenti in metallo, in grado di ottenere una rifrazione decisamente migliore. Dopo innumerevoli tentativi e lunghe notti di osservazione, coadiuvato dalla sorella Caroline, scoprì Urano. Questo gli diede notorietà, il titolo di Astronomo del Re, con una rendita che gli permise di dedicarsi a tempo pieno all’astronomia e uno stanziamento per la costruzione di un potente telescopio. Fu il primo a realizzare un modello della Via Lattea ed avanzò l’ipotesi che gli ammassi di quelle che sembravano nubi, che si osservavano in lontananza nello spazio e che erano stati per questo chiamati Nebulose, fossero anch’esse delle lontane galassie. All’epoca, non c’era modo per osservarle meglio né era possibile misurarne la distanza. Solo dopo la morte di Herschel si trovò un metodo, la “Parallasse”, con il quale, prendendo l’angolo dell’oggetto osservato nei due estremi dell’orbita della terra intorno al Sole, si riusciva con una formula trigonometrica a misurare distanze fino a 300 triliardi di km. Era ancora soltanto un piccolo pezzetto di universo.
Per andare avanti occorreranno altri 200 anni e l’intuizione di Henrietta Swan Leavitt, un’astronoma che pur facendo un lavoro di secondo piano in un ambiente decisamente maschilista (non le era permesso di usare il telescopio) è stata capace di cambiare per sempre la nostra immagine del cosmo. Henrietta lavorava all’osservatorio di Harvard e si occupava della catalogazione delle Variabili Cefeidi, stelle pulsanti la cui luminosità varia nel tempo. La Lewitt intuì che la luminosità è connessa al tempo di pulsazione: stelle con ugual tempo di pulsazione hanno stessa luminosità. Quando osserviamo luminosità diverse su stelle di pari pulsazione, proprio tenendo conto del grado di luminosità, è possibile determinare la distanza. Sfruttando questa intuizione, Edwin Hubble, dall’osservatorio di Los Angeles, calcolò la distanza di una Cefeide osservata nella nebulosa di Andromeda: distava da noi circa 2.500.000 di anni luce ed è una galassia a sé stante.
Oggi, grazie a questi e altri contributi, sappiamo che Andromeda contiene circa mille miliardi di stelle e che la dimensione dell’universo supera i 10 miliardi di anni luce.
Luigi Vecchione
ginius2@gmail.com