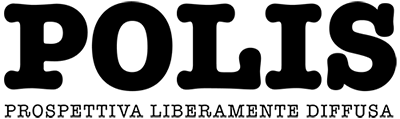Sembra ovvio, ma è comunque utile ricordarlo: le notizie sono un prodotto da vendere. Rispondono a orizzonti di aspettative talvolta ben definiti, codificano una percezione della realtà che si ritiene largamente condivisa, guardano ai desideri espliciti e impliciti del pubblico, obbediscono alle esigenze di committenti e inserzionisti. Negli ultimi giorni diversi organi di informazione – non ultimo il quotidiano Repubblica con un articolo firmato da Roberto Rho sabato 26 gennaio – hanno scritto che le aziende italiane sono intenzionate ad assumere quasi mezzo milione di lavoratori nei prossimi mesi. Avranno tuttavia difficoltà nel farlo perché il mercato non offre le figure professionali adeguate o perché i disoccupati semplicemente non hanno voglia di lavorare. Il nuovo giornale Open si è soffermato sul settore della ristorazione spiegando che nel solo mese di gennaio le offerte per camerieri e aiutanti in cucina sono più di 17.000. Mi sono chiesto quali siano le fonti di queste ricostruzioni e ho compreso, in verità senza troppa fatica, che a disegnare tale scenario sono i dati di Unioncamere, l’ente pubblico che rappresenta Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. C’è tuttavia un aspetto rilevante, segnalato da tantissimi utenti attraverso le pagine di Facebook e di altre piattaforme: quali compensi vengono proposti agli aspiranti lavoratori? La cultura partecipativa fondata su commenti, condivisioni ed espansioni narrative aiuta spesso un uso distorsivo della notizia, ma in altri casi riesce anche a stimolare forme di approfondimento. Non siamo solo fruitori del testo, ma siamo artefici della sua continua trasformazione usando le informazioni offerte dall’esperienza diretta, da altre letture, dai racconti ascoltati da familiari o amici. Diventiamo testimoni e raccogliamo testimonianze, generalizziamo vicende individuali e decostruiamo le generalizzazioni. La notizia – oggi come in passato – attraversa la società e acquisisce un senso incontrando microcosmi narrativi, storie che popolano universi individuali, familiari, comunitari. Il mio microcosmo ha la Campania come sfondo e racconta di giovani camerieri con esperienza pluriennale compensati con 30 euro netti per 4 ore di lavoro “legale”, che nel migliore dei casi si trasformano in 8 ore di lavoro reale: 3,75 euro all’ora, non un centesimo in più. Si tratta di cifre allargabili ad altre realtà? Onestamente non lo so. Solo una ricerca articolata e attenta consentirebbe di aprire il sipario su un mondo che rimane ancora in gran parte sommerso. Ma in fondo conta poco: quello che inquieta profondamente è l’uso della fonte che emerge da queste operazioni giornalistiche, il feticismo per il dato quantitativo, l’estrazione dello stesso dato dai contesti di riferimento, il contributo al rafforzamento di vecchi stereotipi o alla costruzione di nuovi luoghi comuni. Oggi più che mai avremmo bisogno di sguardi critici sulla realtà e non di maldestre illusioni di verità.
Pasquale Palmieri
pasqualepalmieri78@gmail.com