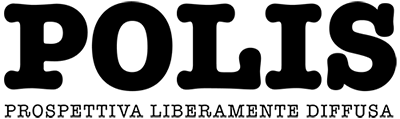L’ultima volta ero stato in Triennale a visitare la mostra “Le mie città” di Gabriele Basilico, il gigante di Bor de Mer, immagini riprese in Bretagna e assolutamente iconiche.
C’erano le sue solite forme asciutte, con le ombre a volte inattese, alcuni scatti a documentare la lotta proletaria, con i lavoratori riuniti attorno a slogan del tipo “Vogliamo l’affitto proletario, dieci per cento del salario”. Battaglie sociali importanti, poi perse, naturalmente.
C’era poi un bel video in cui si vedeva l’artista in una delle città d’arte italiane (Venezia o Firenze), studiava l’angolazione migliore per una foto, in cima a una scala e con un mantello nero che in piena estate portava sulla testa a riparare sé stesso e la pellicola dalla luce eccessiva. Saliva e scendeva dalla scala spostandola di pochi centimetri ogni volta. Cercava la sua perfezione, il suo equilibrio di luce e materia.
Fatta questa premessa, per ricordare a me stesso quanto sia stata bella quella esperienza e dichiarare a tutti il mio termine di confronto più recente, passo a raccontare dell’esperienza al Pirelli Hangar Bicocca. È uno spazio espositivo ricavato all’interno di un ex stabilimento industriale, i volumi sono enormi. Un’area ospita l’installazione permanente dell’artista tedesco Anselm Kiefer, grattacieli fatti di moduli di cemento, un’altra area è destinata a mostre temporanee.
Tarek Atoui era al suo esordio in Italia. Libanese di origini ma residente in Francia, a Parigi, è un artista e compositore elettroacustico. Mai sentito prima di allora, conoscevo il suo linguaggio in quel preciso istante. Sono entrato nello spazio, l’accesso era gratuito, e mi sono trovato dinanzi a un grandissimo ambiente, il cui elemento dominante era il vuoto, con centinaia di metri di cavi stesi al suolo a collegare tra loro i diversi elementi di quella che ho poi interpretato come una sorta di orchestra primordiale. Enormi tamburi coreani erano collegati a microfoni che amplificavano i suoni scoperti dall’artista: quello di una goccia che di tanto in tanto cadeva in un recipiente di marmo, quello di un carosello che faceva ruotare e strisciare su un piatto di pietra delle punte in ceramica di varie forme e dimensioni, ognuna autrice della propria particolarissima vibrazione. C’erano delle cabine di legno e plexiglass al cui interno era possibile entrare per percepire il suono e le vibrazioni prodotte da quegli stessi tamburi. C’erano delle macchine fatte di oggetti collegati tra loro in modo precario, che faticosamente ogni volta, a ogni giro, producevano, quasi “fortuitamente”, verrebbe da dire, il programmato risultato sonoro. Ogni cosa era collegata a ogni altra e le macchine, disseminate in quel vasto ambiente, si attivavano in modo apparentemente casuale: mentre cercavo di capire come funzionava una macchina, se ne attivava un’altra che mi tirava a sé con un suono sordo, o con una forte vibrazione. Il visitatore si trova, quindi, a rimbalzare da un angolo all’altro, trasportato dall’artista in un walzer di curiosità e scoperta. Non ho memoria di altre mostre così coinvolgenti, si potrebbe stare lì dentro per un giorno intero a cercare di comprendere come l’artista abbia concepito quel tutto. E non sarebbe tempo perso.
Mario Fontana.