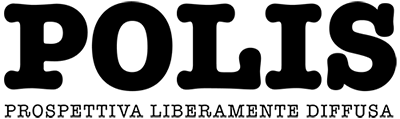In Italiano ricordare è ripassare attraverso il cuore. Risuonare nello stesso punto quella corda che è il cuore, cor cordis in latino, quella stringa cosmica che è il cuore e rimanere in quel suono, con tutto il tuo corpo, farsi informare da quella forma che è un suono. Riviverlo dunque nel caso dell’olocausto, per quanto è possibile riviverlo nel cuore, e piangere, piangere trasformando l’acqua dolce in acqua salata, portare il fiume al mare. L’acqua alla sorgente in acqua salata sapiente, perché questo facciamo quando piangiamo. E sentirlo quanto fa male non essere umani e giurare dentro in silenzio nell’altare delle vene, tra il fegato e i polmoni: Mai più. Mai più. Mai più. Mai più… Perché è successo già troppe volte. Perché sono morti nel vento e li abbiamo respirati e fanno parte della nostra carne ormai. E se li tradiamo ancora, tradiamo noi stessi. E allora saremo noi a morire.
Mai più
E poi sì ci sono stati tanti massacri nella storia. E tanti ce ne sono ancora a dimostrazione che di quell’olocausto, di cui tanto si parla, non abbiamo davvero fatto tesoro. Eppure, credo ci sia davvero qualcosa di speciale in quello tedesco della seconda guerra mondiale. Quello è stato pianificato ed era il frutto evidente di una civiltà raffinata. Non l’inevitabile epilogo di una barbarie, della crudeltà, non un corollario della perdita del senno e della bestialità, ma il frutto della raffinata cultura tedesca, coniugata certo alle solite care vecchie paure, su cui fare leva all’infinito. Ma ragionandoci e cercando di giustificarle per non vergognarsi, cercando di creare un sistema filosofico e scientifico per sostenerle e diffonderle. È uno sterminio figlio di una cultura che lo teorizzava e lo giustificava cercando motivazioni storiche e mitiche, coniugandolo con una perfetta efficienza ed organizzazione. In verità io penso che lo sterminio e il rifiuto dell’altro siano sempre l’esito di una cultura, ma spesso si rivestono di ferocia e di bisogno evidente di sopraffazione, del bisogno banale e grossolano di affermarsi e occupare più spazio. Normalmente si basano su un’avidità molto basilare, quasi semplice, quasi banale. Nel caso del nazismo si è trattato del frutto evoluto tecnicamente ed esteticamente della separazione del sé dal sé. Non c’era nulla di animale in quello, di ferino e feroce: era perfettamente educato, tecnicamente organizzato, esteticamente immaginato e pianificato. E questo lo rende davvero terribile. Terribile e in qualche modo affascinante allo stesso tempo. Affascinante come la morte sul ciglio di una strada che non puoi non guardare. Immaginare un medico che ha studiato per alleviare le sofferenze umane che fa esperimenti su esseri umani vivi ascoltando musica classica a volume altissimo per coprire le loro urla è violento per la coscienza in un modo davvero lancinante, al punto che le parole davvero non bastano. E immaginare quale muro il dottore in questione abbia dovuto ergere dentro sé stesso per zittire le parti fondanti del cervello umano, costruito attraverso i neuroni specchio per essere empatico, illumina l’etimologia della parola cattivo di una luce torrida e accecante.
Cattivo
dal latino captivus – prigioniero
Di chi è prigioniero in parte o totalmente e per questo non può comprendere altro da sé
Non c’è spazio
Non c’è aria
Non è libero di essere se stesso
Vive in cattività
ed è dunque cattivo
Fintantoché i nazisti sono lì perversi, terribili e cattivi e noi siamo qui buoni consapevoli e accoglienti quello che è accaduto non serve a nulla ed è destinato in vari modi a ripetersi all’infinito, finché non saremo disposti ad accettare che un nazista sotto mentite spoglie ce lo portiamo in corpo anche noi e magari siamo quasi sempre capaci di farlo ragionare e di abbattere il muro che erge di tanto in tanto di fronte alla differenza. Ma ogni volta che rifiutiamo l’altro, ogni volta che l’altro ci risulta insopportabile e condannabile. Ogni volta che ci fa schifo, lo separiamo da noi abbastanza da poterci comportare con lui come se non avesse i nostri stessi diritti. E questo è sempre l’inizio della fine, dell’umanità e del buon senso, in nome di un’ideologia. Perché tutti quelli che inneggiano alla giornata della memoria si identificano sempre solo con le vittime, ma i carnefici li brucerebbero volentieri nel rogo. È un discorso che sento fare sempre. Li brucerebbero costringendoli dunque a continuare a tornare, visto che le loro componenti interne che risuonano di quei stessi principi vengono negate e se una cosa la neghi, la condanni ad esistere e a manifestarsi perché tu la possa vedere, comprendere, accettare ed integrare in un modo organico e fertile. È facile essere accogliente con l’altro finché ci assomiglia o finché è innocuo. L’altro è anche il fascista che tu chiami stronzo e che sei felice di vedere per vendetta penzolare a testa in giù. So che questo discorso non riceverà l’appaluso, ma so anche che è una questione matematica e non morale e che io li applausi mai li ho cercati e dunque, mi devo arrendere alla ragione, spogliata della morale. Tutti siamo preziosi. O lo siamo Tutti o non lo è nessuno. A livello scientifico e filosofico è questo il punto. Se partissimo da questo assioma, come fa per l’appunto la parola dignità ricalcata sulla parola “assioma” greca, la società cambierebbe a velocità mai sperimentate finora e invece pretendiamo di giudicare noi chi sia meritevole e chi non lo sia… E questo testimonia la nostra per ora, e solo per ora, invincibile ignoranza. Se tu per valutare le cose ti basi sul visibile, che è una minima, risibile parte di ciò che esiste, non hai alcuna speranza di prendere decisioni sensate. Nel passato la Giustizia era una dea bendata, esattamente come la Fortuna. Ben Data, esattamente come la Fortuna, data bene proprio perché non lasciandosi incantare dal visibile teneva conto per prendere le sue decisioni dell’intero. Cosa che noi, dalla posizione in cui siamo, non siamo minimamente in grado di fare. E dunque fidiamoci della parola dignità che dice che ogni essere umano, per il semplice fatto di avere un corpo ed essere qui con noi in questo piano d’esistenza, ha una indiscutibile dignità, anche se a noi sembra un emerito stronzo, anche se a noi sembra un pericoloso pazzo.
Dignità
D ignità
Se la D rappresenta in greco ed ebraico il 4 e la materia, e Ignis in latino è il fuoco allora la dignità è la condizione per cui la materia manifesta il fuoco. La dignità è ciò che riscalda, illumina e brucia. Il sangue caldo che corre, gli occhi che vedono, l’ossigeno che ci alimenta. Conferma con limpidezza che la dignità umana non sia frutto dell’etica ma del principio di fuoco che ci anima tutti indistintamente. Un essere umano, e a ben vedere anche un animale, non ha dignità per come si comporta, ma perché esiste perché la sua materia è animata dal fuoco. È degno perché il fuoco lo abita. Forse in questo periodo storico dovremmo ricordarlo.
P.S. Dopo averla scritta ho cercato l’etimologia e quello che ho scoperto è sorprendente. La parola latina “dignità” è ricalcata sul greco “assioma”, che significa contemporaneamente assioma e dignità, come se la dignità fosse un assioma che non può essere messo in discussione, ma un dato di fatto da cui partire. Esattamente il ragionamento che è nato sotto sale, anche se nell’etimologia latina non vi è traccia di questo percorso. Con questo non dico che si debba accettare tutto supinamente, non sto dicendo che bisogna lasciare che chi si comporta contrariamente alla dignità umana lo faccia indisturbato e se avete compreso questo rileggetelo. Chi mi conosce sa che non accetto mai nulla supinamente, ma nell’esercizio costante del pensiero la medaglia bisogna guardarla da entrambe le parti se si vuole avere una speranza di comprenderla. E i problemi finché non li comprendi (in te) non hai alcuna speranza di risolverli (fuori di te).
La foto è di un lavoro che feci tanti anni fa per il calendario della Regione Veneto del 2000. La stampai io. È un lavoro di riflessioni che attende da allora un compimento, esattamente come le nostre riflessioni sulla dignità umana. Ho buone speranze per il futuro ed il compimento di entrambi.
Claudia Fabris
ratacla@libero.it